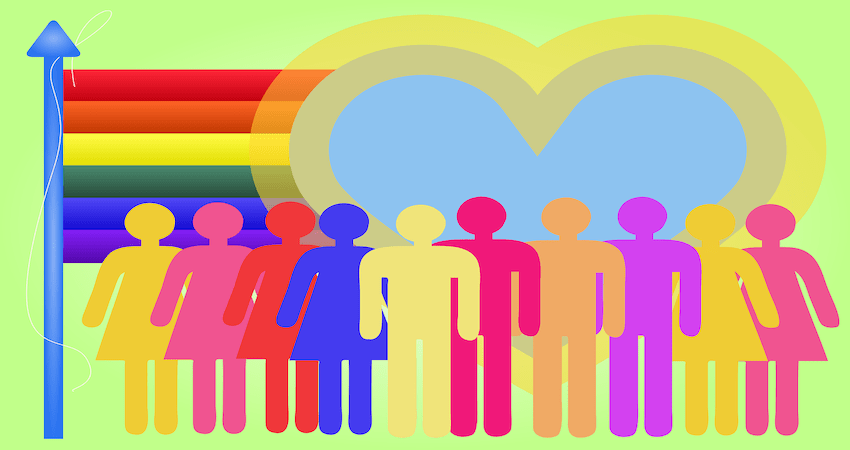Diritto alla cittadinanza e barriere all’apprendimento linguistico

Con una recente pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall’art. 14, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132), nella parte in cui non esonera dalla prova di conoscenza della lingua italiana il richiedente la cittadinanza affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivanti da età, patologie o disabilità, purché debitamente certificate da una struttura sanitaria pubblica.
La disposizione censurata, nel subordinare l’ottenimento della cittadinanza alla dimostrazione del possesso di un livello di competenza linguistica almeno pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, ometteva qualsiasi previsione derogatoria o esimente nei confronti di soggetti in condizione oggettiva di impossibilità o rilevante difficoltà nell’assolvimento di tale onere, configurando così una disciplina rigidamente uniforme, priva di adeguate clausole di flessibilità.
La Corte ha ritenuto che una simile impostazione si ponga in contrasto, in primo luogo, con l’art. 3, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona. In secondo luogo, è stata rilevata la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3, primo comma), nella misura in cui la norma produce effetti discriminatori a carico di soggetti che si trovano in condizioni oggettive e non transitorie di minorazione, senza alcuna valutazione della concreta possibilità di soddisfare il requisito linguistico.
La decisione della Consulta si colloca nel solco di un orientamento volto a promuovere un’interpretazione sistemica del diritto alla cittadinanza, inteso non solo come status giuridico formale, ma anche come strumento di effettiva inclusione sociale e di piena partecipazione alla vita pubblica. In tale ottica, l’automatismo della prova linguistica, svincolato da ogni considerazione circa la condizione soggettiva del richiedente, risulta sproporzionato e lesivo del principio di uguaglianza sostanziale.
È importante sottolineare come la Corte non metta in discussione, in sé, la legittimità dell’introduzione di requisiti linguistici ai fini dell’ottenimento della cittadinanza – coerenti con la finalità di favorire l’integrazione e la coesione sociale – ma ne contesti l’applicazione generalizzata e indifferenziata. La previsione di esoneri, limitata a ipotesi puntualmente certificate, non intacca l’impianto generale della riforma, ma lo rende compatibile con i vincoli costituzionali.
La sentenza sollecita un bilanciamento più attento tra l’interesse pubblico all’integrazione linguistica e il rispetto della condizione personale dei richiedenti, anche alla luce dei principi derivanti dal diritto dell’Unione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che impongono di evitare discriminazioni indirette fondate su caratteristiche personali quali l’età o la disabilità.