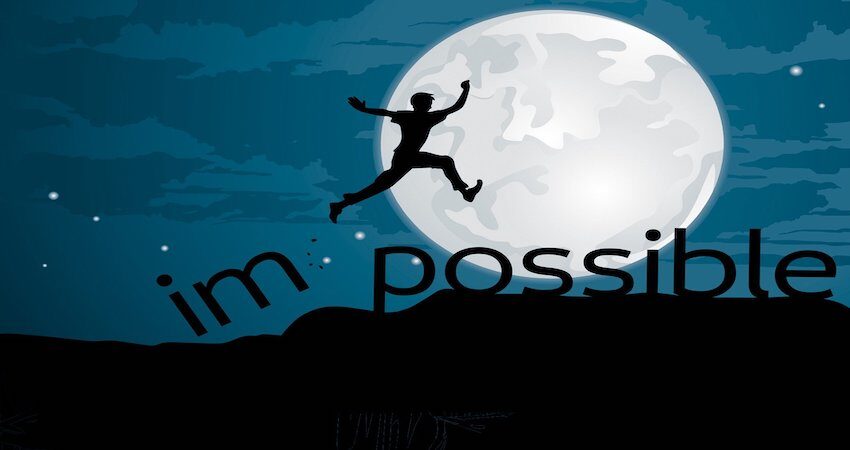Dinamiche psicosociali nei processi di inclusione

Il contesto organizzativo è innanzitutto un contesto sociale. Non stupisce, pertanto, che sia caratterizzato dalle dinamiche tipiche delle relazioni sociali sebbene contraddistinte dal fatto di realizzarsi all’interno di un sistema strutturato da regole, rappresentazioni (organigrammi, funzioni, ruoli, ecc…) e processi qual è appunto l’organizzazione d’impresa.
Possiamo osservare alcune dinamiche virtuose, tipiche dei gruppi sociali e organizzativi, quali l’interazione, l’identificazione, l’inclusione, l’appartenenza, il conflitto, la affiliazione. E allo stesso tempo non è escluso che si possa assistere alla degenerazione delle relazioni e di conseguenza dei vissuti dei singoli e dei gruppi stessi attraverso processi quali l’esclusione, la marginalizzazione, l’espulsione, la discriminazione, e così via.
Proprio gli aspetti sociali e la loro ricaduta sul benessere dell’individuo sono al centro del complesso concetto di “salute” che l’OMS identifica come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un ’assenza di malattia o d’infermità». Una concettualizzazione della salute che poi è permeata nella normativa sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro (art.2 d. lgs. n. 81/08). Creare quindi le condizioni per uno “stato di completo benessere” vuol dire considerare anche quegli aspetti sociali che governano il mondo delle relazioni organizzative.
Tale riferimento normativo non è isolato nel sistema giuridico italiano. Basti pensare all’art. 2087, cod. civ., sui doveri del datore di lavoro rispetto alla tutela dell’integrità (anche morale) del prestatore di lavoro.
Tali norme, lette alla luce dell’art. 3 Cost., si rivelano di grande utilità. Per tale via, infatti, il datore di lavoro non è obbligato solo a valutare la presenza di ostacoli alla piena realizzazione personale del lavoratore, ma deve attivarsi per la loro rimozione laddove siano già sussistenti e per la loro prevenzione se ne può prevedere l’insorgenza.
Vi sono tutti gli elementi sul piano normativo per considerare doverosa la creazione di un diversity climate aziendale, ove il rispetto delle esigenze dei lavoratori, la loro accettazione e apprezzamento sono la manifestazione di un contesto accogliente ed inclusivo in grado di garantire la prevenzione dei rischi psicosociali (Hofhuis J., Pernill G. A. , Vlug M., 2016).
Ma quali sono gli ostacoli di carattere psicosociale non tanto alla piena realizzazione personale, quanto alla libera espressione e partecipazione attiva alla vita aziendale da parte del lavoratore?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo considerare due aspetti fondamentali: il contesto in cui gli eventi avvengono e le dinamiche che in cui esso si realizzano.
La Teoria Generale dei Sistemi (TGS) di L.Von Bertalanffy del 1968 ci invita a pensare ai sistemi sociali come sistemi complessi dove ogni azione è effetto di un’interazione precedente e contemporaneamente causa dell’interazione successiva.
Un approccio sistemico che Gregory Bateson prima e Paul Watzlawick poi, portarono rispettivamente all’interno del contesto famigliare e della comunicazione evidenziando come l’interazione porti all’emersione specifica, contestuale e unica di caratteristiche frutto dello scambio continuo dei singoli componenti l’interazione stessa in cui ciascuno è “causa” ed “effetto” dell’interazione.
Ecco perché il comportamento di un individuo è comprensibile solo all’interno del contesto in cui lo stesso si realizza. Ed ecco perché il manifestarsi di una condizione di disagio, anche conseguente a una specifica dinamica sociale, non solo si può e deve leggere comprendendo le dinamiche che in quel gruppo si realizzano e le specifiche interazioni che le generano, ma può essa stessa rappresentare il “sintomo” del malfunzionamento del gruppo e/o dell’intera organizzazione.
L’interazione tra i membri del gruppo e la sua importanza nell’economia psicologica dell’individuo fu proprio oggetto di studio di Kurt Lewin nel 1948, il quale ne evidenziò la rilevanza nel dare origine a dinamiche quali l’identità sociale, la condivisione di assiomi, di regole e di comportamenti. Tali dinamiche fanno da sfondo allo sviluppo dei processi di rappresentazione del mondo da parte dei gruppi e dei loro membri.
Proprio all’interno di questo mondo, fatto di rappresentazioni, si concretizzano i processi fondamentali per la vita sociale dell’individuo, quali stereotipi e pregiudizi. Essi prendono vita da quelli che sono i meccanismi normali della mente umana, come la categorizzazione e la generalizzazione, che consentono all’individuo di padroneggiare l’estrema complessità degli stimoli ambientali.
Nello specifico, la categorizzazione opera attraverso la rappresentazione in insiemi, degli stimoli ambientali connotandoli dal punto di vista affettivo e valutativo (si pensi alle categorie basate su occupazione, il sesso, l’etnia, la religione, la nazionalità). La generalizzazione, invece, rappresenta la tendenza della mente umana a estendere ad ampie serie di eventi le osservazioni effettuate sui pochi eventi disponibili (si pensi, a quando estendiamo a tutti i componenti di un gruppo le osservazioni fatte solo su alcuni di loro).
Tali meccanismi, al di là della loro assoluta efficacia e il loro essere alla base dei meccanismi di identificazione e appartenenza di gruppo, ci pongono di fronte a dei “limiti”: da un lato, infatti, nell’effettuare le generalizzazioni sono possibili una serie di errori (errori di inferenza) legati alla visibilità (salienza) del dato che si generalizza, dall’altro la categorizzazione ha in sé una forte resistenza al cambiamento (permanenza della categoria)
Dalla combinazione di categorizzazione e generalizzazione nasce lo stereotipo che Allport (1954) considera come la dimensione ideativa delle categorie: un contenuto in termini di immagini fisse, nonché valutazioni e aspettative che solitamente si aggiunge alla categoria per descriverla, anche per giustificare e razionalizzare la nostra condotta in relazione ad essa.
Al termine stereotipo si aggiunge quello di pregiudizio inteso come giudizio anticipato rispetto alla valutazione dei fatti, caratterizzato da superficialità, generalizzazione e rigidità che solitamente porta con sé il rifiuto di metterne in dubbio la fondatezza dell’atteggiamento stesso e di verificarne la consistenza e la coerenza (Allport, 1954).
La realtà, quindi, a causa della sua estrema complessità, non può essere conosciuta in quanto tale, bensì solo attraverso le immagini mentali o rappresentazioni che l’uomo se ne crea (W. Lippmann, 1922). Tali rappresentazioni sono basate su semplificazioni (gli stereotipi, appunto) che consistono in forme di organizzazione preventiva dei dati. Tale organizzazione dei dati, in una logica di “economia cognitiva”, influenza la raccolta e la valutazione dei dati relativi alla realtà osservata (cose, persone, situazioni, gruppi), ovvero ci porta a raccogliere informazioni che confermano idee che già abbiamo (da qui la ricorsività e persistenza degli stereotipi). Tali stereotipi hanno origine prevalentemente sul piano sociale, derivando essenzialmente dal contesto culturale e questo spiega, ancora una volta, come l’analisi dei comportamenti (derivanti da processi di categorizzazione, generalizzazione, ecc…) sia realizzabile solo in considerazione del contesto e delle dinamiche che li caratterizzano.
L’individuo è quindi condizionato nel suo agire non da una certa situazione quale essa oggettivamente è, ma dalla sua percezione soggettiva e dalla sua definizione attraverso stati emozionali, progettualità e storia personale che danno forma ad atteggiamenti che interagiscono costantemente con i valori e gli atteggiamenti sociali. Risulta quindi estremamente difficile, se non impossibile, pensare e agire in maniera significativamente diversa da quella che è strutturata e imposta dal sistema culturale in cui la persona vive.
Una volta formatosi, lo stereotipo contribuisce al mantenimento della categoria dal momento che impedisce un “pensiero differenziato” (Allport, 1954, 266-7). Ciò è vero anche nei rapporti tra gruppi, come ha evidenziato Tajfel denominando il fenomeno “accentuazione percettiva” (Tajfel H. , Wilkes A.L., Classification and quantitative judgement, 1963).
È anche sulla base di questi processi (appartenenza e pregiudizio) che arriviamo a fenomeni sociali complessi e per certi versi devastanti come il razzismo. Sono questi processi, queste scorciatoie mentali, chiamati bias cognitivi che da un lato ci permettono di economizzare le energie mentali e velocizzarne l’esito nel brevissimo periodo, ma dall’altro lato possono determinare errori di valutazione e quindi comportamenti errati.
All’interno dell’organizzazione, i bias rappresentano un elemento di studio fondamentale: pensiamo, per esempio, alla loro importanza nei processi di valutazione dei collaboratori o in processi come la selezione del personale in cui l’imparzialità (Mor Barack, Cherin e Berkman, 1998) è (o meglio, dovrebbe essere) elemento imprescindibile. In tali contesti, il maggior ostacolo da superare sono gli stereotipi e pregiudizi che risiedono in tutti i livelli della struttura organizzativa e spesso si annidano nei processi finanche negli algoritmi (cfr. M. Brollo, F. Bilotta, A. Zilli, Lessico delle dignità, 2021).
Le scorciatoie mentali (euristiche) permettono quindi di ridurre la complessità delle valutazioni e delle previsioni semplificando le operazioni di giudizio (bias), ma possono condurre a errori gravi, sistematici e impliciti (Tversky & Kahneman, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases,1974).
Data la loro importanza e pervasività nella vita sociale e organizzativa, e considerati gli effetti che essi producono sia a livello di gruppo che sul piano personale, è necessario chiedersi come si possano superare i bias cognitivi.
Di certo, la consapevolezza è la chiave per ridurre l’influenza dei bias cognitivi sui nostri processi di scelta. Sapere che i bias cognitivi esistono e possono distorcere le nostre decisioni e relazioni aiuta a diminuirne la presa: studiarli, conoscerli e cercare di riconoscerli in noi e nei processi organizzativi è un primo passaggio per la loro gestione.
Se è possibile gestire i bias (ri)conoscendoli e gestendoli è altrettanto possibile, pur se più complesso, governare l’articolato fenomeno dei pregiudizi, partendo proprio dalla loro conoscenza e riconoscibilità nei nostri atteggiamenti. Sono proprio gli atteggiamenti, in quanto predisposizioni sufficientemente stabili a reagire in modo costante nei confronti di specifici oggetti sociali e a guidare le nostre azioni. Affrontare i pregiudizi vuol dire ridurne la forza: occorre agire sulla conoscenza diretta e partecipata dell’oggetto sociale e, dove possibile, collaborativa con le persone o gruppi verso cui quel pregiudizio è forte.
Da qui, ancora una volta, la necessità di addivenire a una cultura organizzativa autoriflessiva, che stimoli la conoscenza reciproca. Dalla conoscenza, emergeranno le singolarità e si abbatteranno i muri del pregiudizio e ancor prima l’attitudine al giudizio, forte deterrente alla libera e profonda espressività individuale.