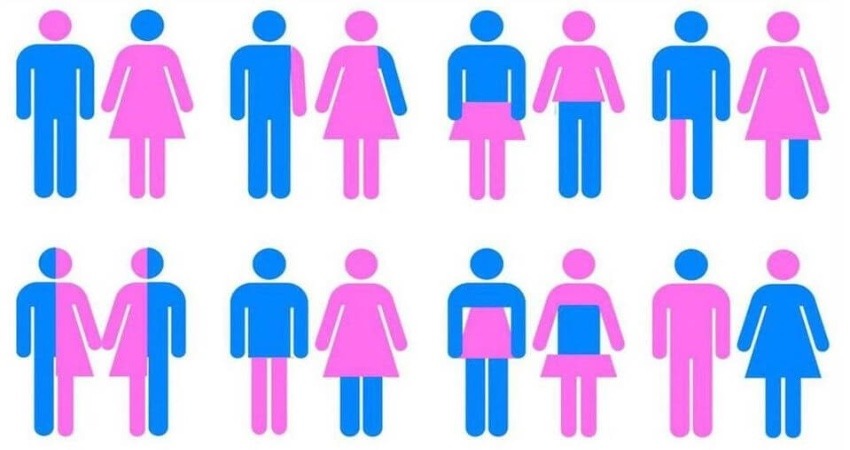Genere o generi? Questo è il problema: un libro di Fabiana Fusco

Nel suo saggio La Rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859. Osservazioni comparative, Alessandro Manzoni scriveva che «il linguaggio è stato lavorato dagli uomini per intendersi tra loro, non per ingannarsi a vicenda». Alla maggior parte delle persone la parola chiave di questo enunciato potrà sembrare linguaggio, e non si può negare che tutto, in tale periodo, ruoti attorno alla potenza della parola e alla sua capacità di essere plasmata dall’essere umano proprio come patente della sua umanità. A chi, invece, ha una qualche abitudine a trattare questioni di genere, la parola chiave dell’enunciato non potrà che apparire uomini. Sono gli uomini come esseri umani a lavorare sulla lingua? Certamente. Ma sono stati per secoli anche e soprattutto gli uomini come esseri umani di sesso maschile a lavorare sulla lingua. L’opacizzazione linguistica di tutto ciò che non è uomo (inteso come maschio eterosessuale bianco cisgender maturo occidentale neurotipico normodotato) è una precisa cifra stilistica degli utilizzatori di molte lingue, non ultima l’italiano, da secoli, ma trova ancora oggi frange di strenua difesa.
Proprio dalla necessità di concedere visibilità al non maschile nella lingua prende le mosse tutto il filone di studi sul sessismo linguistico che affonda le radici nelle prime esplorazioni di Alma Sabatini a metà degli anni Ottanta dello scorso secolo; in tale corrente si inserisce il volume di Fabiana Fusco Genere o generi? Questo è il problema…Consigli linguistici per un uso attento e consapevole della lingua italiana, uscito nel marzo 2022 per i tipi di Forum editrice (il file del volume è liberamente scaricabile).
L’autrice inaugura il suo libro contestando la diffusa credenza che la lingua sia un fatto per così dire asettico, che occorre in una sorta di “vuoto pneumatico” in cui si staglia in tutta la sua purezza. Al contrario, chiarisce Fusco, la lingua non è né asettica né tantomeno asessuata, e il suo utilizzo in un modo o nell’altro è un preciso atto politico che ci qualifica come esseri umani facenti parte di una società organizzata.
In apertura del secondo capitolo, Fusco fa una preliminare quanto necessaria specificazione su cosa si intende quando si parla di genere. A un significato di genere meramente legato alla grammatica, al volgere tra vecchio e nuovo millennio si è affiancata, su impulso culturale dell’angloamericano, l’accezione di genere come insieme delle «differenze socialmente costruite fra i due sessi» e dei «rapporti che si instaurano tra essi in termini di comportamenti distintivi» (p. 17). Nelle lingue è pertanto possibile parlare di genere in diverse forme. Vi sono lingue che dispongono di una cosiddetta marcatura grammaticale di genere, ossia quel processo che permette di marcare il genere con elementi morfo-sintattici: è il classico caso di termini come gatt- che, a seconda dell’elemento che scegliamo di inserire alla fine (-o, -a, -i, -e), modificano il proprio genere e anche il proprio numero. Nelle lingue del mondo vi sono anche numerosi casi di genere lessicale, cioè di possibilità di esprimere il genere del referente attraverso elementi del lessico del tutto diversi (come nel caso di padre/madre, due parole differenti provenienti da diverse radici). Infine, in tutti i fatti di lingua si può e si deve considerare il genere sociale, che non riguarda la lingua in sé quanto piuttosto le aspettative socio-culturali – spesso stereotipate – che ogni società carica sugli individui in base al loro genere di appartenenza e che, giocoforza, si rispecchiano nelle manifestazioni linguistiche. A partire da questa riflessione, Fusco spiega come sia non solo lecito, ma anche doveroso, interrogarsi sul portato culturale di alcune scelte linguistiche che, a un occhio poco allenato, possono sembrare innocue, ma che in realtà veicolano precisi sistemi di pensiero. Tra esse, la più evidente è quella del cosiddetto “maschile sovraesteso”, sovente utilizzato per riferirsi a moltitudini in cui è chiara la presenza femminile, o addirittura per riferirsi a ruoli, persone e situazioni in cui gli uomini non sono per nulla presenti e l’unica referenza extralinguistica è di genere femminile: è ciò che accade quando, ad esempio, si scrive lo studente deve presentare domanda di laurea rivolgendosi a tutta la comunità studente, oppure quando, entrando in una stanza dove la presenza femminile è ben evidente se non addirittura maggioritaria rispetto a quella maschile, si salutano le persone presenti con un buongiorno a tutti. A tali scelte (p. 24 e ss.) si può rispondere con diverse strategie, come quella della femminilizzazione della lingua, «ovvero la specificazione del sesso dei referenti tramite esplicite marche di genere», oppure quella dello splitting, cioè «la reduplicazione della forma, come i professori e le professoresse»; ancora, si può ovviare con precise istanze di neutralizzazione di genere, esprimendo i concetti tramite l’uso di termini generici e non marcati, nomi collettivi o pronomi indefiniti (l’utenza, la presidenza, chi usufruisce del servizio, etc.), oltre che con modifiche di tipo sintattico che prevedono, ad esempio, la scelta della forma passiva (la domanda deve essere presentata presso gli uffici di segreteria) o di quella impersonale (si presenta domanda presso gli uffici di segreteria). Tutte queste riflessioni partono, naturalmente, dall’assunto che nessuna lingua è sessista strictu sensu, ma possono essere sessisti gli usi che della lingua fanno le persone che la parlano, incardinate in un sistema culturale che prevede l’opacizzazione del femminile come situazione comunicativa di default, rispetto alla quale qualsiasi altra scelta di campo risulta marcata.
Nel terzo capitolo del volume, l’autrice propone alcune delle principali obiezioni che – sulla scorta di un certo conservatorismo di facciata – vengono avanzate contro l’uso di un linguaggio corretto e inclusivo dal punto di vista del genere, avendo cura di decostruire quelli che spesso sono solo meri pregiudizi figli del sentito dire con rigorosi contrappunti scientifici. Se la presunta cacofonia dei femminili viene liquidata rapidamente come fatto pertinente alla sensibilità soggettiva, dunque non passibile di assurgere a regola generale, più spazio viene dedicato all’obiezione sulla reale utilità di tali femminili, ove il maschile potrebbe occorrere in loro vece e ricoprire un ruolo “neutro”. In realtà, spiega Fusco (p. 35 e ss.), in italiano non esiste il neutro, e se esistesse non ci sarebbe bisogno di declinare al femminile tutti quei termini, specialmente professionali, come maestra, cuoca, infermiera. Perché, a fronte di questi femminili esistenti e consolidati, ai quali nessuno imputa cacofonia o inutilità – guarda caso riguardanti mestieri di cura, assistenza o didattica, ai quali le donne sono sempre state tradizionalmente relegate – si sente poi invece l’esigenza di una levata di scudi quando si declinano al femminile termini professionali che alludono a ruoli apicali come avvocata, ministra, sindaca, ingegnera, medica? Anche all’obiezione sulla mancanza di una regola chiara che indichi quando usare i femminili, tale per cui risulta più sicuro avventurarsi su terreni noti – cioè sul maschile sovraesteso – Fusco risponde che le uniche regole a cui appellarsi sono quelle della grammatica, che mostrano chiaramente come formare i femminili di ogni nome a seconda del contesto. Infine, l’obiezione del benaltrismo, che vorrebbe spostare l’attenzione su questioni di volta in volta ritenute molto più importanti della lingua (come la parità di diritti, le questioni salariali, le discussioni su sanità, politica ed economia in generale) è puntualmente depotenziata dall’autrice attraverso una riflessione sulla necessità, più che di costruire una volubile e soggettiva “scala delle priorità”, di lavorare su piani paralleli, modificando ciò che non va nella nostra società non solo ma anche, perché no?, partendo da questioni linguistiche.
Nel medesimo capitolo l’autrice (p. 46 e ss.) va avanti spiegando che scegliere un linguaggio inclusivo e corretto dal punto di vista del genere, lungi dall’essere una vernice politically correct di facciata, si configura come un vero e proprio rispetto di quella grammatica che i detrattori dell’istanza vorrebbero dipingere come minacciata. Indirizzandoci con un maschile a una referenza femminile, infatti, rischiamo di costruire frasi imperfette dal punto di vista sintattico, qualora gli altri elementi presentino un accordo di genere basato sulla referenza extralinguistica e non sul termine utilizzato. In poche parole, riferendoci a una sindaca in visita presso una scuola, se volessimo usare il maschile per il solo titolo professionale ma il femminile per gli altri elementi frasali, dovremmo proporre la frase il sindaco, accompagnata dalla giunta comunale, si è recata in visita presso una scuola, con evidente straniamento di chi legge. Inoltre, queste scelte non fanno altro che rinnovare i nostri cosiddetti gender bias (p. 46-47), cioè quei pregiudizi introiettati per cui, a fronte di un nome maschile, abbiamo maggior tendenza ad associare a quel ruolo figure maschili e a vedere una donna che lo ricopre come un deragliamento dalla normalità.
Nel quarto capitolo del lavoro, Fusco si chiede se si possano realmente proporre interventi concreti sulla lingua che siano cauti e misurati, dunque passa in rassegna tutte le possibili modalità e casistiche di formazione del femminile già presenti in italiano. Prima di questa esplorazione, tuttavia, l’autrice fa una digressione sugli usi di maschile e femminile in funzione di chiarezza e coesione testuale, riprendendo il discorso avanzato già nel capitolo precedente. Lungi dall’essere una decisione solo morfologica, quella dell’uso corretto del genere è infatti una pratica che ha anche numerose conseguenze in sintassi e negli accordi con i modificatori di ogni sostantivo. Pertanto, quando le casistiche si fanno complicate e il mantenimento di tutti gli accordi doppi renderebbe il testo poco fruibile, Fusco avanza la proposta di utilizzare quello che lei stessa chiama “maschile inclusivo” (p. 59 e ss.), cioè una forma linguistica di maschile sovraesteso non, però, presentata come Vangelo inappellabile e come unica forma legittima, bensì preceduta da un disclaimer variamente inteso che possa far capire che le istanze di genere sono ben presenti e rispettate, ma che in quel contesto si preferisce una comunicazione più snella e si demanda l’inclusione all’interpretazione di chi legge. Ciò, precisa ancora Fusco (p. 60-61), permetterebbe di uscire dalla dinamica della «cospirazione linguistica» e di utilizzare, ove possibile, «un solido e pratico espediente che consente di evitare lo sdoppiamento maschile e femminile (splitting) dei nomi e degli elementi target (aggettivi, pronomi, participi passati, ecc.)». Ciò premesso, verso la fine del capitolo l’autrice sottolinea ancora una volta come questi espedienti per l’aumento della fruibilità del testo non debbano comunque mai scoraggiare la continua ricerca di una comunicazione il più inclusiva possibile, né debbano oscurare il femminile tout court (p. 73 e ss.).
L’ultimo capitolo, infine, è dedicato a una breve riflessione su possibili opzioni di sperimentazione per il superamento della logica a due tra maschile e femminile (p. 79 e ss.), come il ricorso a simboli grafici (car*, car_, car@), a spazi vuoti (car tutt ), a un’unione di morfemi di genere e simboli (cari.e, cari-e, etc.) oppure all’uso di fonemi inediti (carə, caru). Secondo Fusco, queste soluzioni generano non pochi problemi, tra i quali l’incerta formazione dei loro plurali e la complicazione della pronuncia di simboli grafici non pensati per la realizzazione fonetica (soprattutto *, _ e @, ma rientra in questa casistica anche lo spazio vuoto). A ciò si aggiunge il senso di straniamento che può portare nell’uditorio il ricorso a fonemi come la /u/ atona finale, che, nonostante sia presente in alcuni prestiti italiani piuttosto diffusi come guru o sudoku, tuttavia non viene mai utilizzata come morfema marcatore di genere (ed eventualmente di numero), pertanto è un’innovazione davvero complicata da imporre nella lingua manu militari senza l’accordo delle persone parlanti. L’autrice, dunque, ritiene queste forme (pp. 81-82) assai interessanti da usare «in testi scritti o trasmessi di natura privata o anche professionale ma indirizzati a comunità coese e in accordo su certe scelte di campo», laddove reputa invece poco navigabile «la possibilità di avvalersene in produzioni istituzionali o pubbliche destinate anche alla lettura ad alta voce, perché la decodifica del contenuto da buona parte dei lettori/ascoltatori potrebbe risultare ardua e generare negli stessi un sentimento di disorientamento».
La conclusione dell’autrice a valle del suo volume è di concretezza ma anche di speranza. Da una parte, infatti, Fusco è perfettamente consapevole del fatto che i cambiamenti si scontrano sempre con un certo ostruzionismo, e anche del fatto che risulta davvero difficile intervenire nella lingua delle persone, dal momento in cui, come diceva Alma Sabatini nel suo Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, «toccare la lingua è come toccare la persona stessa». Dall’altra, tuttavia, l’autrice mostra apertura e fiducia verso il futuro, in particolare verso la capacità della comunità accademica di far comprendere alla comunità parlante l’importanza di queste istanze, non smettendo mai di fare divulgazione e informazione sugli argomenti della parità di genere e dell’equa visibilità. Il fine ultimo di tutto ciò è quello di creare un terreno di coltura all’interno del quale ogni innovazione potrà germogliare non perché imposta ma perché condivisa dalla cittadinanza.